Opere 1908 - 1922
materiale
tratto dal catalogo "GAETANO MARTINEZ SCULTORE" curato da
FEDERICA RIEZZO e GIANCARLO GENTILINI
(per gentile
concessione dell'editore ENRICO FILIPPUCCI -
R&R Editrice
)
-------------------------------------
Artista
autodidatta nel vero senso del termine (non conseguì neppure la
licenza elementare) Gaetano Martinez apprende da giovanissimo,
nella città in cui nasce, Galatina, i primi rudimenti dell'arte
dello scalpellino di pietra leccese.
Lavorando con il padre, titolare di una piccola impresa edile,
il giovane Gaetano inizia a scolpire lapidi funerarie (Lapide di
Anna Maria Codazzo,I.2) e ad abbellire le facciate di alcune
abitazioni con intagli in pietra leccese (Villa Lisi, I. 3)
attingendo ad un repertorio eclettico che cita soprattutto
modelli quattrocenteschi ma anche motivi del repertorio moresco.
II primo tentativo
di un trasferimento a Roma, avvenuto nel 1911 ma conclusosi solo
due anni più tardi apporta un decisivo aggiornamento ai suoi
studi basati sull' ammirazione sconfinata per
Michelangelo: nel Dolore Umano del 1915 (I. 5) il simbolismo
decadente si fonde alla sinuosità soffusa di Bistolfi per dare
vita ad un' opera in cui, più che la sofferenza evocata dal
titolo, è espressa una malinconica dolcezza.
Le opere
successive nascono invece dal sovrapporsi di un'altra componente
su quella classicheggiante: il verismo che si ricollega alla
scuola napoletana di Gemito e d'Orsi, un verismo che si distacca
nettamente dall'eredità dei grandi scultori salentini come
Eugenio
Maccagnani e Antonio Bortone, caratterizzala da
un'interpretazione in chiave monumentale e celebrativa.
L'approccio di Martinez, che non sconfina mai nella denuncia
sociale, si distingue per un modo di guardare agli "umili" del
tutto privo di paternalismo ma venato da un vago evangelismo che
potrebbe trovare un corrispettivo letterario nel mondo
deamicisiano.
La scelta di soggetti del quotidiano porta in questo momento ad
opere riuscite, come il sogno del piccolo giocatore (I. 8), ma
anche a quadretti "di genere" verso i quali lo scultore si sentì
spinto, come egli stesso racconta, da "ragioni economiche
dolorose"
1.
Mentre nel Sogno del piccolo giocatore, che si accosta allo
stile del leccese Giurgola, è ravvisabile uno spiccato accento
poetico che predomina sulla resa dettagliata del vero, I'osservazione
minuziosa e quasi fotografica inficia ritratti come Giovane
popolano del 1917 (I. 9) e Ritratto del 1918 (I. 13).
Il filosofo
(I. 10) si accosta invece al gusto archeologico e neocinquecentesco di Gemito e Cifariello.
Ma sono anche Rodin e Medardo Rosso i modelli cui Martinez
guarda in questi anni di formazione: in Fanciulla (I. 17) e nel
Wagner (I.11) il richiamo ad una scultura che renda la fusione
con I'atmosfera si traduce in una modellazione scabra. quasi
abbozzata.
Ragazzo imbronciato (I. 16) del 1919, Scugnizzo del 1920 (I.
19), Bimbo assonnato del '21 (I. 22) rappresentano Ie tappe di
uno stile che, dal naturalismo narrativo, passa all'acquisizione
di una sintesi volumetrica più moderna. Ma segnano anche la
predilezione per i soggetti del mondo dell'infanzia ritratti in
atmosfere di mesta rassegnazione che sembrano presagire un
destino di rinunce. su cui lo scultore riversa un'onda di tenera
partecipazione: un'infanzia che si accosta allo spirito del
concittadino Toma.
D'altra parte la scelta di raccontare i turbamenti, Ie
sofferenze dell'uomo è enunciata in modo chiaro in un passo
databile tra il 1917 e il 1919:
"L'artista farà vera opera d'arte quando egli stesso si commuove
di quello che fa. I grandi pensieri e Ie grandi cose nascono a
colui che ha maggiormente sofferto".
2.
Una sofferenza dovuta in questi anni all' intolleranza verso I'ambiente
retrivo che lo circonda e che lo spingerà ad inseguire il sogno
di gloria nella capitale.
1. Notazione autografa posta sui retro della foto del
Nudo
riverso. I.4.
Archivio Minafra, Galatina.
2. A. Vallone.
Gaetano Martinez, in
"Nuova
Antologia", aprile 1975, p. 586.
|

I.1
Allegoria dell'Estate,
1911 dat.
bassorilievo, terracotta dipinta, cm. 70x51 x7
Galatina.
Rosa Alba Martines.
In alto a destra: "G. M. 1911".
Fra le opere datate di Martinez a noi note questa
risulta la più precoce,
e compare, insieme ad altri simili rilievi di soggetto
allegorico e
mitologico (tra i quali il n. r. 2), in una foto d'epoca
con I'iscrizione
autografa "L'inizio della mia carriera/i
primi lavori / composizioni.
figure da car(toli)ne e di maniera /G. Martinez dal 1908
al 1910"
conservata (come molte altre che segnaleremo nelle
schede successive)
nell'archivio del prof. Carlo Minafra di Galatina.
Si tratta di un bassorilievo decorativo, ispirato dal
mondo c1assico e da modelli cinquecenteschi, secondo
un gusto assai diffuso verso la fine dell'Ottocento,
raffigurante una giovane donna tra putti festanti in
un'ambientazione agreste: probabilmente un'allegoria
dell'estate, o una Venere tra amorini. Le figure
femminili ritratte in chiave
allegorica saranno ricorrenti nella produzione dello
scultore fino
all'inizio degli anni Trenta.
|
|

I.2
Lapide di Anna Maria Codazzo, 1910 ca.
bassorilievo, pietra leccese,
cm. 47x 197 Galatina, Cimitero Comunale.
La lapide sepolcrale, riprodotta insieme ad altri lavori
giovanili in
una foto d'epoca con I'iscrizione autografa "L'inizio
della mia carriera
/ i primi lavori / composizioni, figure da cartoline e
di maniera / G.
Martinez dal 1908 al 1910" (cfr. I. I), fu eseguita
antecedentemente
al primo soggiorno romano (1911). Raffigura un'urna in
forma di croce
incorniciata da motivi floreali di valore simbolico
(foglie di palma e
di alloro, rami di quercia e tralci con capsule di
papavero, etc.)
presso la quale siede un angelo che piange asciugandosi
le lacrime; e
nelle due tabelle laterali, protomi alate, coppie di
serpenti ed altri
elementi decorativi che alludono anch'essi al
trascorrere del tempo,
alla morte e alla resurrezione.
Si riscontra qui una singolare esuberanza decorativa, in
seguito
estranea a Martinez, e un gusto eclettico
neo-rinascimentale che si
sofferma su modelli quattrocenteschi: nella posizione
del putto e
infatti evidente il richiamo al sarcofago del sepolcro
Coscia di Donatello e Michelozzo nel Battistero di
Firenze. |
|

I.3
Decori
architettonici di Villa Lisi,
1914/16 ca.
pietra leccese
Galatina, strada provinciale per Noha.
Le decorazioni, eseguite nel periodo in cui Martinez
apprendeva I'arte
dello scalpellino a Galatina, impreziosiscono la
facciata della villa,
di semplice impianto. I fregi e gli intagli che
inquadrano il portale
d'ingresso e le due finestre laterali rivelano lo studio
di un repertorio eclettico che attinge soprattutto a
motivi moreschi e medioevali,
accordandosi all'indirizzo decorativo prevalente nelle
ville salentine di primo novecento. |
|

I.4
Nudo riverso
dolente (II Dolore Umano ?) 1914-15
statua, creta, grande al vero
Opera non portata a termine e distrutta.
Bibl.: Crespi e
Petrucci 1949, p. 18.
L'opera è documentala da una foto dell' Archivio Minafra,
che ritrae I'autore (di cui però non si scorge il volto)
intento a plasmare un giovane nudo disteso, con la
didascalia autografa: "Primo contatto col vero 1914-15.
Lavoro non portato a termine perché non soddisfatto
benché mio fratello Pasquale mi aiutasse a (sic)
posare".
E' possibile che si tratti di una versione iniziale del
Dolore Umano (I. 5).
Secondo Crespi e Petrucci, in precedenza, "sui finire
del 1914",
Martinez aveva infatti "impostato un nudo grande al
vero, su modello vivente" che "disfece subitamente, per
insoddisfazione".
Prima
significativa "opera di creazione" affrontata dallo
scultore, lo rivela
coinvolto, certo grazie al primo soggiorno a Roma in
occasione
dell'Esposizione Internazionale del 1911, dal simbolismo
tragico ed
esistenziale. che verso la fine del primo decennio aveva
animato gli
scultori italiani più giovani e aggiornati. |
|
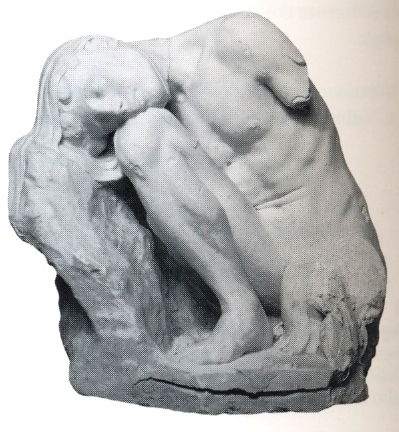
I.5
II
Dolore Umano, 1915 dat.
statua, gesso, cm. 67x65x60
Galatina, Museo Civico (inv.
n. 1 23).
Sulla base: "G. Martinez 1915".
Bibl.: Crespi e Petrucci 1949, pp. 6, 18; Mezio 1955;
Antonaci 1955:
Specchia 1991.
"L'esasperazione del suo anelito" ricordano Crespi e
Petrucci "si
risolve nel titanismo di un nudo che egli chiama "II
dolore umano" e che,
a Galatina, testimonia come il miraggio di una forma
perfetta, animata
da un contenuto sentimento, fosse già, da allora, la sua
più profonda
ambizione" nell'espressione del giovane dal capo
appoggiato languidamente su un masso, ora mutilo del
braccio e della gamba a sinistra, più che la sofferenza
evocata dal titolo, un "dolore" ancora gridato dal
Nudo riverso di poco precedente (I. 4), si può leggere una
delicata dolcezza, un malinconico abbandono.
Simbolismo
decadente e sinuosità bistolfiana si fondono in un'opera
in cui il senso di
sofferenza e affidato, più che alla contrazione dei
tratti somatici,
ad una posizione statica che costringe il corpo, quasi
comprimendolo.
Nella foto dell' Archivio Minafra il giovane non ha Ie
membra mutile:
non siamo però certi che si tratti della medesima opera
data la diversità
della base ove la Figura si appoggia. Da una notazione
autografa apposta
sulla stessa foto, apprendiamo che Martinez si servì,
come modello, di
un operaio di suo padre. E ' da segnalare I'affiorare da
un incavo della
roccia,di un volto: soluzione adottata poi nel Caino. |
|

I.6
Nudo
disteso,
1915
statua, gesso, cm. 47x 167x75
Galatina. Museo Civico (inv.
n. 125).
Bibl.: Confetti 1923: Vannutelli 1925, pp. 133-34:
Crespi e Petrucci
1949, p. 18.
La titolazione generica (talora indicata anche come Nudo al
vero) e la
data si desumono da una notazione autografa su una foto
conservata
nell'Archivio Minafra e dai riferimenti bibliografici
(Crespi e Petrucci). Su un'altra foto Martinez precisa
che l'opera segue a breve distanza la realizzazione del
Dolore Umano, e certamente è orientata nella
medesima direzione.
II giovane, "esautoralo di forze, di una bellezza
plastica e di una tale
armonia e forza anatomica che rasenta I'incredibile" (Vannutelli,
p.
133), richiama infatti nell'abbandono del corpo e nella
torsione del busto, che ripropone quanto sperimentato
nel primo Nudo distrutto (I.4), così come nel braccio
posato sulla fronte, l'iconografia della "sconfitta" o
del "peccato", e quindi del "dolore". di matrice
decadente: tale modello era stato divulgato dalla
pittura di Sartorio ed era molto in voga agli inizi del
novecento. |
|
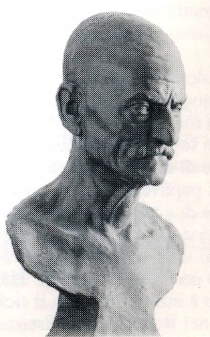
I.7
Ritratto di vecchio (Signor Tondi),
1915 dat.
testa.
gesso dipinto a bronzo, cm. 56x32.5x 17
Galatina, Museo
Civico (inv. n. 61).
Sul retro: "G. Martinez 1915"
Esp.: Roma 1923.
Bibl.: Cancogni 1937.
Su una foto dell'epoca custodita nell' Archivio Minafra
possiamo leggere
la didascalia autografa: "Prima testa dal vero". L'opera
presenta
un'austerità da ritratto classico, ma nella meticolosa
definizione
fisionomica e dell'epidermide emerge quella cultura di
tradizione
verista che qualificherà gran parte della produzione
giovanile di Martinez. |
|

I.8
Il sogno
del piccolo giocatore
(Il piccolo cerinaio sognante),
1917
dat. Statuetta. terracotta. cm. 11 x39x34
Galatina. Rosa Alba Martines.
Sulla base, "Martinez 1917 - II sogno del piccolo
giocatore".
Altri esemplari:
a) Lecce, Museo Provinciale: bronzo (inv. n. 9000);
b)
Matino, Banca
Popolare Pugliese: bronzo;
c) Galatina, Rita Martines:
bronzo.
Esp.: Bari 1917: Lecce 1924 (bronzo).
Bibl.: Confetti 1923: Garatti 1923: Marti 1924. pp.
220-21. 25: Vannutelli 1925, p. 134; Vinci 1925;
Foscarini 1936, p. 256; Crespi e Petrucci 1949, p. 10; Antonaci 1951 e
1955; Petrucci 1971, fig. 155; De MIarco 1981. p. 9; Marrocco 1994, p. 4.
Frutto dell'osservazione della condizione dell'infanzia
nella sua terra, questo scugnizzo ritratto in un momento
di sogno, di abbandono, di arrendevolezza quasi, che
stringe in una mano i dadi, nell'altra Ie
carte. "rivela ... il triste fato d'una indifesa
moltitudine di adolescenti" (Vinci) costretti dalla vita
a destreggiarsi e a lottare
contro molte tentazioni, e talvolta a cadervi, a causa
della loro miseria. Nel percorso stilistico degli anni
precedenti al trasferimento a Roma, caratterizzato da
inclinazioni naturalistiche, I'opera
rappresenta una tappa rilevante, per la felice sintesi
tra ispirazione e resa formale e per il suo essere
sintomatica di una vera e propria
temperie spirituale delI'epoca, di un modo di guardare
agli "umili",agli "sconfitti".
L'atteggiamento di Martinez non sconfina mai nella denuncia sociale né è
animato da alcuna carica eversiva, come invece spesso
succedeva nel verismo a sfondo sociale. Resta piuttosto
nell'ambito dell' umana commozione, delIa pietà,di quel
richiamo ad un vago evangelismo che in letteratura aveva
trovato espressione in Edmondo De Amicis e Mario Rapisardi, facendo dello scultore una
sorta di erede spirituale della pittura del conterraneo
Gioacchino Toma. Influenzata dal verismo di Gemito e
della scuola napoletana. (ricordiamo II giocatore
di carte di Vincenzo Gemito, di analogo soggetto, e
II
riposo del pastoreIlo di Raffaele Belliazzi), si può
accostare ad opere del leccese Raffaele Giurgola, come
lo Scugnizzo oggi presso la "Società Operaia"
di Lecce, di poco precedente (1916).
Come ricorda
Alfredo Petrucci II piccolo cerinaio, "cotto in un forno
di mattoni",venne esposto nel 1917 alla Mostra di
Artisti Pugliesi allestita presso il Circolo Artistico
di
Bari in Palazzo Fizzarotti dallo stesso Petrucci,cui lo
scultore ancora
"povero ed ignorato" I'aveva sottoposto insieme a
numerosi disegni; e fu
questa "Ia prima volta che Martinez prese contatto col
pubblico".
L'esemplare in bronzo, presso il museo di Lecce, è stato
acquistato il 27 luglio del 1988, mentre quello
attualmente di proprietà della Banca di Matino è stato
venduto da uno degli eredi il 3 gennaio 1995. |
|

I.9
Giovane popolano,
1917
testa, terracotta
Ubicazione ignota.
Bibl.: Lancellotti 1926.
L'opera, nota da una foto dell' Archivio Minafra, con la
datazione 1917,
e dai giornali dell'epoca, è anch'essa legata alla
lezione di Gemito e al verismo "di genere" della scuola
napoletana di fine Ottocento;
indirizzo che peraltro consentiva un considerevole
riscontro commerciale. |
|
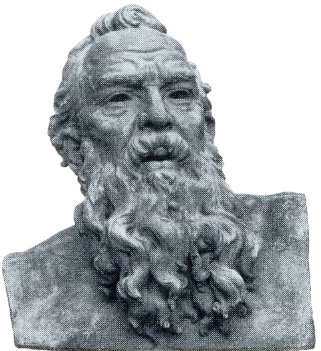
I.10
II
filosofo,
1917 dat.
erma, terracotta patinata, cm. 50x46,5x39
Galatina,
Museo Civico (inv. n. 121).
In basso, a sinistra: "il filosofo Martinez dicembre
1917".
Bibl.: Coi 1997, p.39.
E' senza dubbio il michelangiolesco Mose I'archetipo
più diretto di questa testa, condotta con un fare
naturalistico accentuato nelle rughe che solcano il
volto, ma soprattutto nei volumi esuberanti della barba,
che "danno vita ad un'ideale cascata materica che dal
volto si getta
freneticamente" verso il basso (Coi).
Questi aspetti possono richiamare la scultura di Filippo
Cifariello con il quale Martinez entra in contatto in
occasione della sua
partecipazione ad una "Promotrice" napoletana,
chiedendogli anche di entrare come discepolo nel suo
studio. D'altra parte nel taglio ad erma e nelle orbite
scavate I'opera si accosta al gusto archeologico di
Vincenzo Gemito, incline anch'egli in specie
nell'attività tarda, a virtuosistici e dichiarati
recuperi della scultura del Cinquecento. |
|
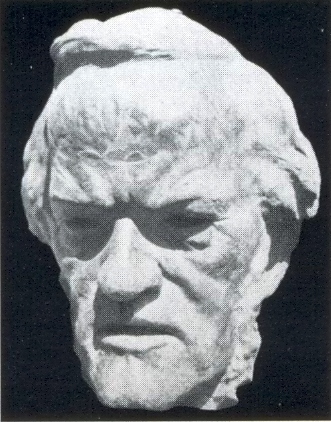
I.11
Wagner, 1918
maschera, terracotta dipinta a bronzo, cm. 25,5x22x 19,5
Galatina, Rita Martines.
Sulla parte superiore: "G. Martinez".
Altri esemplari:
a) Galatina, Rita Martines: bronzo;
b)
Ubicazione ignota: bronzo.
Esp.:Roma 1923 (Casa d'Arte Palazzi); Roma 1924: Milano 1932.
Bibl.: Vannutelli 1925, p. 134: Vinci 1925; Lancellotti
1926: Ruinas
1927: A. V. in ''La Gazzetta del Mezzogiorno", 1932; S.
M. in "La Puglia Letteraria", 31 gennaio 1933: Foscarini
1936, p. 256.
Condotta con fare impressionistico, a metà strada tra
Rodin e Medardo Rosso, questa "maschera vigorosa" (Ruinas)
ha colpito la critica soprattutto per la capacità
di cogliere, con pochi tratti, la fisionomia del genio
intento a concepire la sua creazione, a captare
un'intuizione. Secondo Vinci, è "impressionante" il modo
in cui lo
scultore è riuscito a rendere e quasi a materializzare
la statura morale
dell'uomo tratteggiandone la fisionomia.
D'altra parte I'opera sembra imparentata con altre
effigi di musicisti celebri assai diffuse, attraverso
repliche in bronzo e gesso, nell'arredo
borghese di inizio secolo, come la popolare
maschera funeraria di Beethoven e il celebre busto di
Giuseppe Verdi realizzalo da Gemilo nel 1873. Un
esemplare in bronzo fu acquistato nell'aprile del 1941
dalla
Confederazione Fascista dei Professionisti e degli
Artisti di Roma. |
|

I.12
Lapide
di Costantina Ripa de Serafini,
1918 ca.
bassorilievo, pietra
leccese cm. 46.5x95
Galatina, Cimitero Comunale.
In basso a destra: "M. G."
La lapide raffigura un angelo che depone un mazzo di
rose presso un sepolcro, dal quale emerge una figura
evanescente, allusiva all'anima della defunta (e forse
un suo ritratto). L' opera, rispetto alla lapide
funeraria realizzata nel 1910 ca. (I. 2) denota I'
aggiornamento del gusto e dei modelli di riferimento di Martinez dopo il primo soggiorno romano, denunciando un
accostamento alle tematiche simboliste con una palese
attenzione all'esempio di Bistolfi, ormai referente
privilegiato e quasi d'obbligo per la scultura
decorativa di epoca Liberty, e soprattutto per la
scultura funeraria. |
|
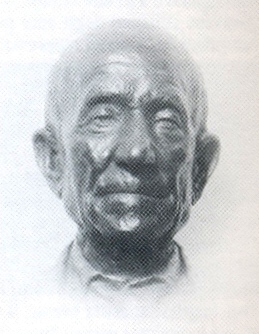
I.13
Ritratto (Mio zio),
1918
testa, terracotta
Ubicazione ignota.
Bibl.: Serra 1940.
L'opera è attentamente commentata dal Serra, che nota
come "Ia ricerca di una forma volumetrica pura" si
coniughi ad una descrizione dei
lineamenti e dell'abbigliamento "troppo fotografica, pur
rivelando una non comune penetrazione ed acutezza nel
cogliere i segni del disfacimento senile". |
|
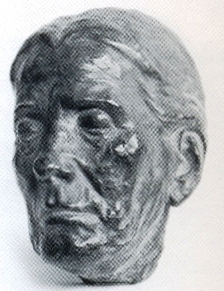
I.14
Ritratto
della zia (Nonnina),
1918
testa, bronzo
Ubicazione ignota.
Esp.: Galatina 1979.
Bibl.: Serra 1940: Miccoli 1979 (fig. 6).
Opera di concezione analoga alla precedente (I.13), ma
con una modellazione più fluida e impressionista, che
denota un'inclinazione a
superare I'eredità verista, più presente - come e ovvio
- nella ritrattistica. |
|
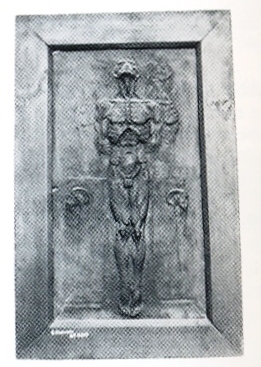
I.15
Composizione allegorica
(Allegoria del sacrificio ?), 1918-19 dat.
bassorilievo, terracotta patinata con cornice in legno,
cm. 77.5x44
Galatina, Museo Civico (inv. n. 81).
In basso a destra: "G. Martinez 918-19" .
Sulla cornice, a sinistra: "G. Martinez - studio".
L'opera, di accentuata impronta simbolista, presenta una
Figura nuda di uomo ripetuta da tre punti di vista,
davanti ad un'ara ardente. Potrebbe
essere interpretata come un'allegoria del sacrificio dei
caduti della prima guerra mondiale (nella quaIe era
morto il fratello Carlo), come studio per una targa
commemorativa ad essi dedicata.
Nella composizione schematica e nella modellazione
geometrizzata, astrattiva, Martinez sembra ora guardare
alla linea 'secessionista' (affermatasi in Italia
proprio in occasione dell' Esposizione romana
del 1911 da lui visitata) . Forse alla scultura di
Cambellotti, Zanetti e Wildt, orientandosi già verso
quella stilizzazione formale che caratterizzerà la sua
produzione intorno al 1925. |
|

I.16
Ragazzo imbronciato,
1919
statua, terracotta
Già Milano, Silvio Monti.
Titolo, data e proprietario sono desunti da una
notazione autografa su una foto dell'epoca custodita
nell' Archivio Minafra.
L' opera presenta ancora molti punti di contatto con iI
naturalismo "di genere" della scuola napoletana (efr.
I.
8). Ma la modellazione 'impressionistica' raggiunge qui
una maggiore violenza espressiva, che,
unita a notazioni più crude (le 'scarpacce' enfatizzate
come nella scultura di Meunier), allinea Martinez col
verismo sociale di primo Novecento.
II sentimento di mesta rassegnazione che in quest'opera,
e in altre che la seguiranno in questa fase, come il
Bimbo assonnalo del '21 (I. 22),
avvolge bimbi e adolescenti sembra dovere molto
all'infanzia ritratta dal concittadino Toma: un'infanzia
"da orfanotrofio", malinconica e
silenziosa, su cui I'artista riversa un'onda di
tenerezza.
Nella Scheda informativa compilata nel 1933 per
l'Archivio Storico d'Arte Contemporanea di Venezia, alla
voce "possessori delle opere principali" Martinez
indicherà solamente "il costruttore Silvio Monti",
proprietario di quest'opera. |
|
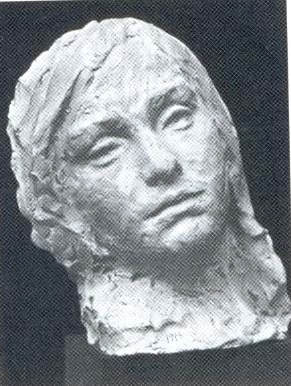
I.17
Fanciulla,
1919-1920 dat.
Testa, terracotta, cm. 25x23x 17
Galatina,Rosa Alba Martines.
Sul collo, a sinistra: "1919"
sui capelli, a destra: "G. M. 920".
Altri
esemplari:
a) Galatina, Mariapia Martines: bronzo;
b)
Matino, Banca Popolare Pugliese: bronzo
Esp.: Roma 1939
("Galleria di Roma"): Galatina 1986 (a).
Bibl.: Maselli 1939; Serra 1940; Crespi e Petrucci 1949,
tav. I;Petrucci 1971, fig. 158; M. e R. Martines 1986 (fig.
18); Marrocco 1994, p. 2.
Ulteriore testimonianza del periodo giovanile
influenzato dall' impressionismo di Medardo Rosso, cui
Martinez guarderà di nuovo intorno al 1940-45,
questa testa è ritenuta da Serra un episodio effimero
nel percorso dello scultore, che si sarebbe accostato ad
uno stile non profondamente sentito, scadendo in un "decorativismo
fragile nella sua vaga eleganza". Come nel Wagner
(I.11). il richiamo ad una scultura che renda
efficacemente I'impressione di fusione con lo
spazio circostante si traduce in un modellato scabro,
quasi abbozzato alla Rodin; il bronzo, oggi di proprietà
della Banca di Matino, è stato acquistato il3 gennaio
1995 da uno degli eredi. |
|
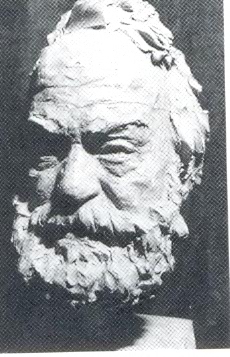
I.18
Carducci,
1920 ca.
Testa, terracotta, cm. 32x23x23
Galalina, Carlo Minafra.
Esp.: Napoli 1920.
Bibl.: Foscarini 1936, p. 256.
Per la sua tempra morale, la figura di Carducci
impressionò vivamente Martinez che lo ritrasse
anche in numerosi disegni e lo menzionò più
volte nei suoi appunti. Non a caso è questa una delle
prime opere esposte dallo scultore. |
|
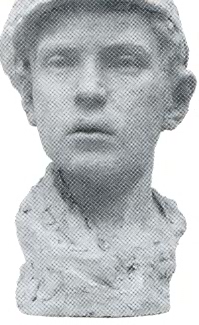
I.19S cugnizzo
(Popolano con berretto), 1920 dat.
t esta, terracotta,
cm. 34x19,5x22,5
Galatina, Rosa Alba Martines.
Sui collo, a sinistra, "G. Martinez 920".
Esp.: Bari
1974; Galatina 1981; Bologna 1982.
Bibl.: De Pisis 1925; P. S. in "II Messaggero", 16
febbraio 1937;Marino 1971; Miccoli-Colazzo 1974, p.2,
fig. 1; De Marco 1981, p. 5; Bellonzi
-Servolini 1982, p. 6.
Ancora fortemente influenzata dal naturalismo
ottocentesco della scuola napoletana questa testa unisce
alla rudezza e alla velocità del modellato alla Medardo
Rosso (del quale sembra rievocare il celebre Scugnizzo,
detto anche il Birichino) la ricerca di una sintesi
volumetrica più moderna.
L'opera piacque molto a De Pisis che la osservò nel '25,
in occasione di una sua visita allo studio di Martinez:
"ricordo anche" egli scrisse, "una bella testa di
ragazzo in terracotta che non ha nulla da invidiare a
certe teste ... che si ammirano come oracoli in certi
Musei". |
|
I.20
Volto di donna ,
1920 dat.
bassorilievo, gesso, cm. 45x45
Galatina, Museo
Civico (inv. n. 15).
In basso, a destra: "G. Martinez 1920".
|
|

I.21
Fanciullo,
1920 dat.
testa, gesso, cm. 32x21 x 12,5
Galatina, Rosa Alba Martines.
Sul collo,adestra:
"G. Martinez 1920".
Altri esemplari:
a) Galatina, Rosa Alba Martines: bronzo
Esp. Galatina
1981; Legnago 1982.
b)
Bibl: Miccoli-Colazzo 1974 [p. 2]; De Marco 1981, p. 7.
Potrebbe trattarsi di uno studio preparatorio per il
Bimbo assonnato dell'anno successivo (I. 22), |
|
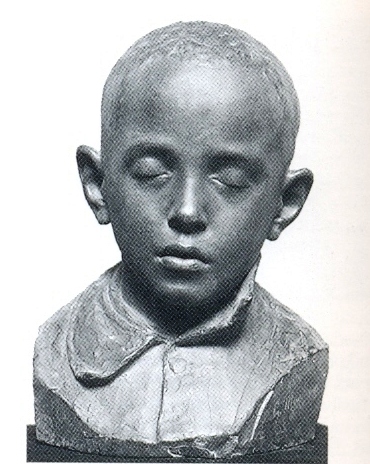
I.22
Bimbo assonnato,
1921
busto, terracotta dipinta Ubicazione ignota.
Galatina, Mario Congedo
In basso, a destra: "G.Martinez"
Esp.: Roma 1939 (III Quadriennale)
Bibl.:A. N. 1939; Maselli 1939,
Serra 1940; Sapori 1949, p. 347; Petrucci 1971, fig. 159.
L'opera, nota da una foto dell'Archivio Minafra e dalla
bibliografia, è fra le più riuscite del "periodo di
provincia", e registra il progressivo affrancamento dal
naturalismo narrativo a favore di una più avanzata
ricerca volumetrica (ravvisabile soprattutto nella forma
molto regolare della testa) e di un sentimento più
concentrato e indefinito.
Martinez sembra cogliere un momento di stanchezza di uno
scolaretto sui banchi di scuola, fermando come in
un'istantanea fotografica il passaggio dalla veglia al
sonno. "Un lembo del colletto sollevato, le labbra un
po' cadenti, gli occhi chiusi, quel lieve cadere della
testa.
Le orecchie a sventola" denotano un'attenta "ricerca del
vero"(Serra). |
|
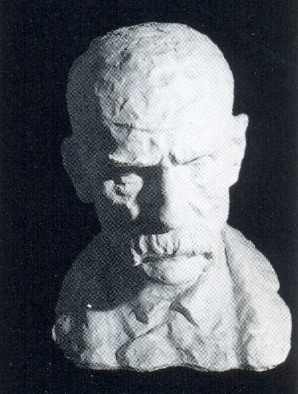
I.23
Ritratto
di vecchio, 1922
dat.
testa, gesso, cm.
41x33x30
Galatina, Museo Civico (inv. n. 65).
A destra: "G.
Martinez 1922".
|

|